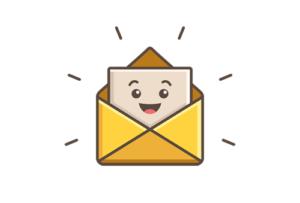In Bulgaria li chiamano kukeri. Portano maschere coloratissime e copricapi iperbolici. È un rito che l’Unesco nel 2015 ha dichiarato patrimonio dell’umanità.
Dioniso è vivo e danza insieme a noi.Annunciato dal suono dei campanacci, dal lamento delle zampogne, dal battito ostinato degli zoccoli di legno del suo seguito di maschere, di bipedi caproni, di montoni minacciosi, di orsi maliziosi, di fantasmi incappucciati, di spiriti cornuti.
Che avanzano caracollando e saltellando come un corteo di zombies.Ma non ballano il moonwalk come i morti viventi che vanno dietro a Michael Jackson.







Kukeri 
Mezzogiorno News
Il loro passo ha la misteriosa inquietudine del passato che non passa. È la piroetta straniata di una storia stratificata come una geologia. E che ci fa tornare per incanto all’alba dell’uomo. Quando umani, piante e bestie erano ancora una cosa sola.
Una bella d’erbe famiglia e d’animali, avrebbe detto Ugo Foscolo.In Bulgaria li chiamano kukeri, che vuol dire incappucciati, dal latino cuculla, cioè cappuccio.Portano maschere coloratissime e copricapi iperbolici, dorati, colorati, allungati, esasperati, borchiati. È un rito che l’Unesco nel 2015 ha dichiarato patrimonio dell’umanità e che si celebra anche in Romania, in Russia e in Serbia.
In realtà è quel che resta delle cerimonie agrarie dei Traci, i popoli che abitavano queste terre prima dei Greci e dei Romani. E proprio qui è nato il culto di Dioniso, che per gli antichi popoli europei non era soltanto l’allegro dio del vino, il signore della vite.
Ma anche quello della vita, della linfa di un arbusto in fiore, del sangue che pulsa nelle vene di un giovane animale, e nei furori eroici ed erotici di donne e uomini in amore. Insomma tutti i misteriosi e incontrollabili flussi vitali che scorrono nelle arterie della natura.
Proprio per questo Dioniso veniva raffigurato come un capro, un animale sacrificato per dare vita alla vita, per rendere fertile la terra, per rinnovare ogni anno il ciclo delle semine e dei raccolti. In Russia li chiamano Ljeschie, da lies che vuol dire bosco, e li identificano con gli spiriti del grano che si nascondono nelle foreste per poi tornare fra gli uomini una volta all’anno sotto sembianze animali.
In realtà nella danza spaesante dei kukeri e dei loro simili mascherati, riaffiora un’arcaica religione del vivente che a tutta prima stride con il paesaggio urbano in cui ormai si celebra il rito.
Eppure superato il primo istante di smarrimento di fronte a immagini che ci sbalzano lontano nello spazio e nel tempo, riaffiora il fondo primigenio di una domanda di rassicurazione e di protezione, profondamente umana. Che noi cittadini globali abbiamo rimosso, ma che il nostro inconscio culturale custodisce nel suo segreto come un verbale mai abrogato.
È la stessa vertigine da riconoscimento di una dimensione insieme nostra e perduta che ci prende quando assistiamo a riti analoghi in Italia.Come quello sardo dei Mamuttones, che con le loro maschere luttuose e il fragore dei campanacci irrompono nel bel mezzo del carnevale di Mamoiada in tutta la loro tenebrosa potenza. Creature della notte che illuminano la camera oscura della nostra memoria.Questi esseri vestiti di vento, questi survakari incappucciati che avanzano in fila indiana legati come i grani di un rosario, fanno pensare ai ciechi della parabola evangelica, quelli dipinti da Pieter Bruegel.
Mano nella mano per paura dell’ignoto. Mentre un corteo di ragazze vestite di bianco e coronate di rose danzano come lampi di primavera.
«Fin da piccola temevo le maschere», diceva la grande poetessa russa Anna Achmatova, «perché mi pareva che un’ombra in più, senza faccia né nome, s’intrufolasse in mezzo a loro». In realtà nel vortice della danza dei kukeri ad uscire dalla clandestinità e ad impressionare l’obiettivo è proprio l’ombra del nostro io dimenticato.